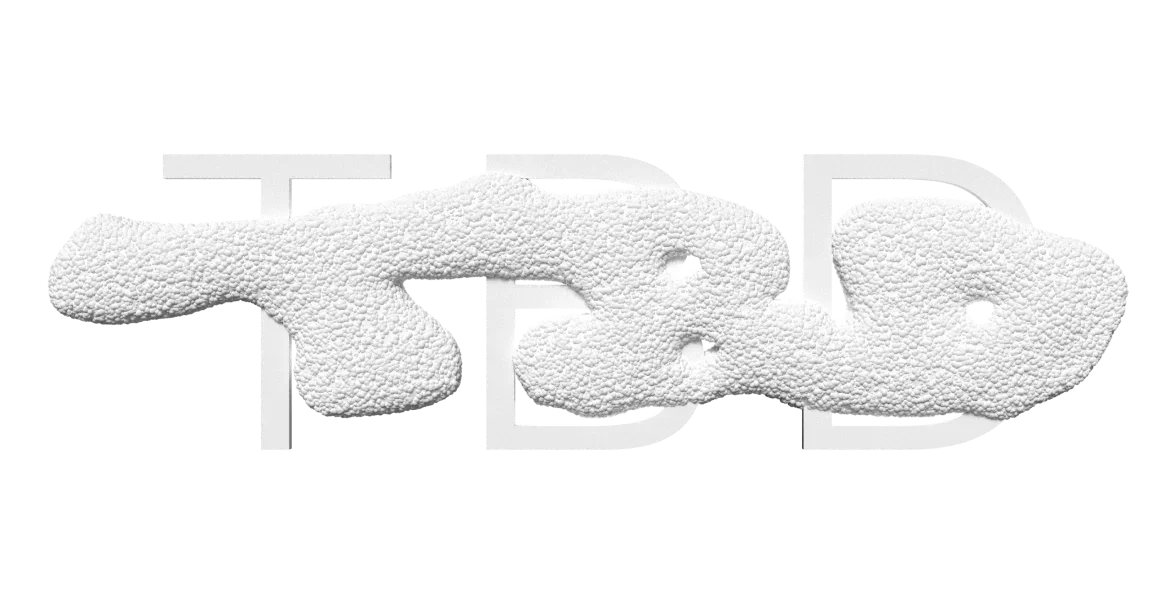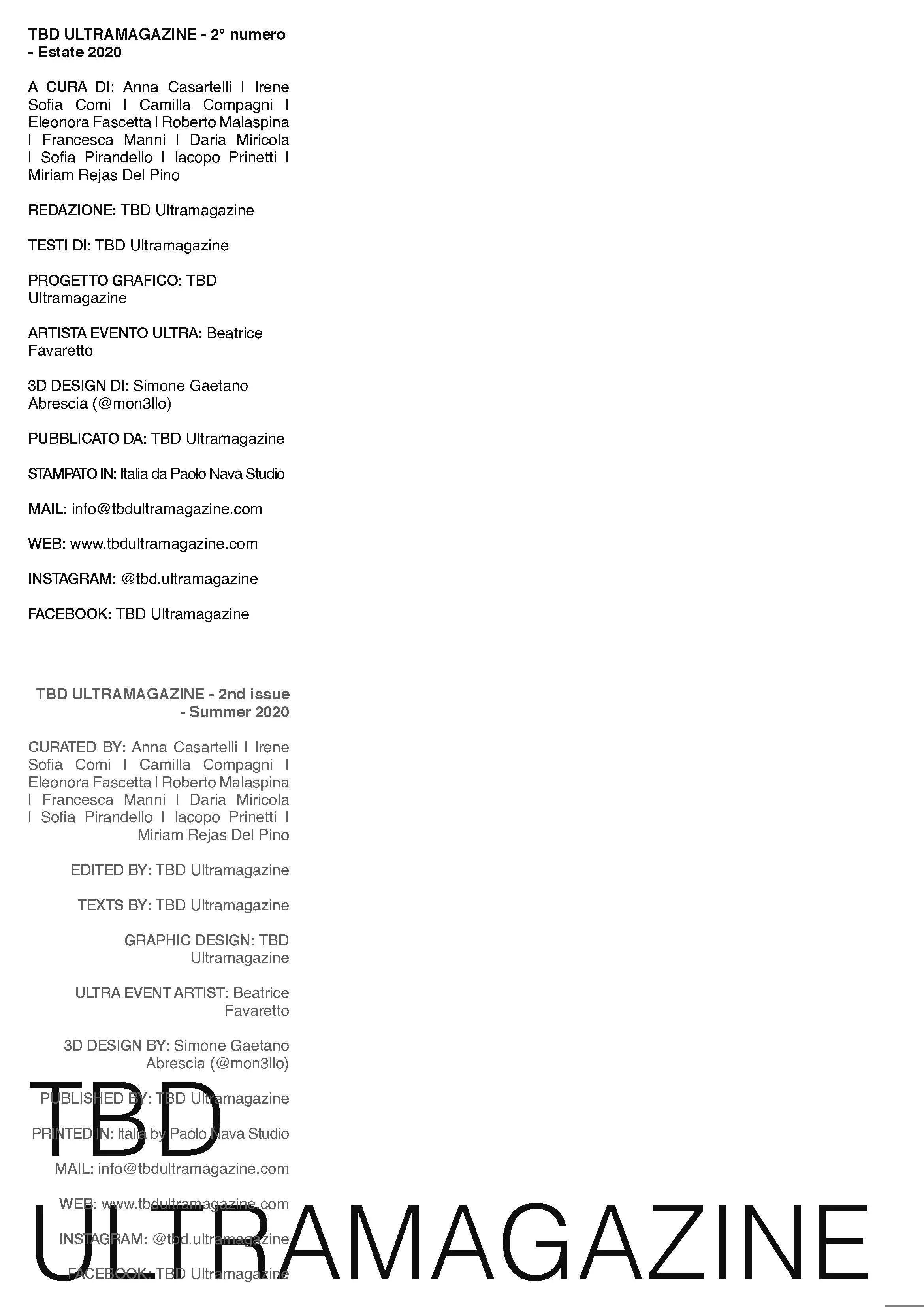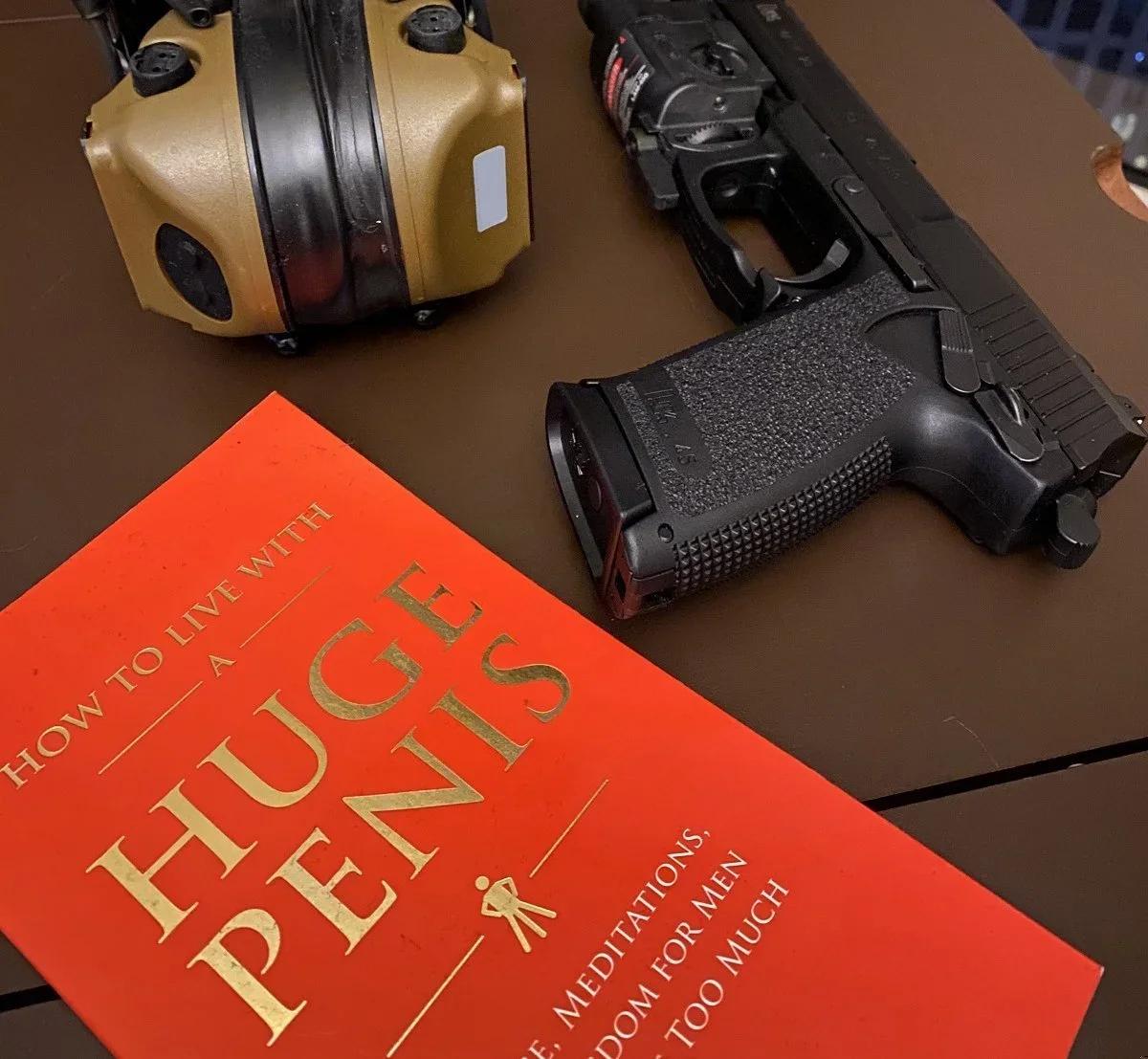NON C'É TEMPO DA PERDERE
La pandemia in atto ci ha colti impreparati sotto molti punti di vista, a cominciare da quello intellettuale. Per chi, come me, si occupa quotidianamente di teoria, la cassetta degli attrezzi è sembrata da subito piuttosto sfornita, inadeguata a descrivere l'attuale situazione di emergenza e a garantire valutazioni e soluzioni che siano utili per tutti. Eppure uno sforzo va fatto, si devono azzardare delle considerazioni perché si possa capire. Prendere appunti su ciò che credevamo di sapere e su quello che viviamo nel presente è forse il primo passo per tentare un bilancio, denunciare delle pieghe problematiche, formulare ipotesi. Se chiudo gli occhi e penso a questi giorni in reclusione, nella testa si agita una folla di immagini: di immagini digitali. Gli schermi dominano il mio quotidiano, l'orizzonte del mio percepito. Fin qui, sembrerebbe, nessuna novità. Gli schermi digitali sono i dispositivi mediali per eccellenza del nostro tempo, superfici operative, che la ricercatrice Galit Wellner propone di considerare al contempo muri e finestre (Wellner 2011). A dire il vero, l'idea che percepiamo il mondo attraverso una finestra si è imposta nella cultura occidentale almeno a partire dall'età moderna, con le leggi rinascimentali della rappresentazione prospettica. Si tratta di una teoria che affonda le sue radici nella convinzione, ampiamente diffusa già nell'antichità, che l'occhio sia la prima finestra attraverso cui ci affacciamo all'esterno, su degli oggetti separati da noi (Carbone 2016). Gli schermi della televisione, del computer, del cellulare, di un qualsiasi smart device abitano lo spazio vissuto e quotidiano, sono una presenza ubiqua, portatile e alle volte indossabile. L'esperienza schermica digitale è oggi pervasiva, gli schermi sono la nostra finestra, e anche di più. In questo caso non abbiamo a che fare soltanto con una metafora impiegata a fini euristici: si tratta effettivamente di una via di accesso a un contesto di una differente materialità rispetto al mondo fisico, eppure reale (Wellner 2011). Secondo Wellner, infatti, computer e smartphone condividono la tendenza a distrarre l'attenzione del fruitore dai suoi dintorni, indirizzandola verso ambienti virtuali altri. In questo senso sono in grado di separarci dal contesto che ci circonda e contemporaneamente di fornire l'accesso a spazi remoti, privati o condivisi. La catalizzazione della nostra attenzione, o meglio,la distrazione dal luogo in cui ci troviamo fisicamente, non è certo esclusiva delle tecnologie digitali e può essere considerata una caratteristica condivisa da tutti i media tecnologici. Attualmente però le tecnologie digitali sono a tal punto diffuse da essere in grado di garantire una costante interconnessione di luoghi e persone: ogni giorno siamo contemporaneamente dove si trova il nostro corpo e dove ci portano gli schermi. Per dirla con Don Inde, veniamo così coinvolti in una 'quasi-illusione' (Wellner 2011). Il significato del termine 'schermo' rimanda a qualcosa che nasconde alla vista, sia nel senso che fornisce una protezione sia nel senso che comporta un impedimento: è una superficie che mette in evidenza qualcosa e che, proprio per questo, contemporaneamente esclude qualcos'altro (Carbone 2016). Ciò che rende visibile è frutto di una selezione, esso mostra secondo le sue modalità delle porzioni di spazio, tempo e informazione, educando bisogni e desideri del fruitore insieme alle sue abitudini percettive. Gli schermi del nostro quotidiano raccolgono immagini, video, testi, consentono di parlare con altre persone e funzionano ormai quasi tutti tramite il tocco delle dita. Onnipresenti e interconnessi, ci guardano mentre li guardiamo, modificando il modo in cui interpretiamo il mondo e in cui ci comportiamo